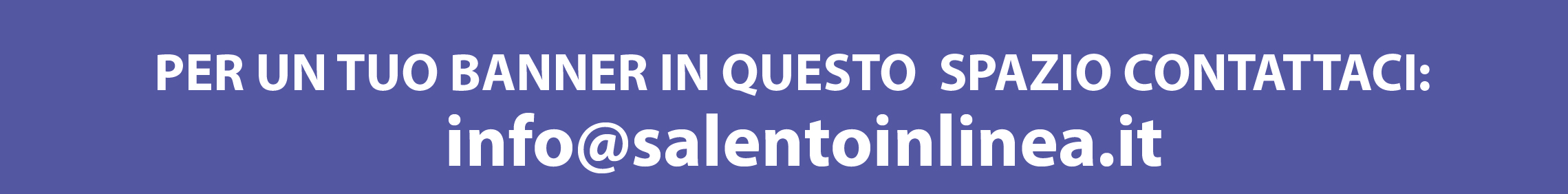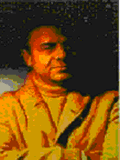 Ho sempre pensato alla parola, per così rivolgermi ad essa, come un immaginario, un raccontare per immagini spesso staccato da terra. E lì, mi dicevo, affossare un po' tutto. Una visione che al tempo stesso era del mondo e staccata da esso, perché lontana da terra, incastonata in un quadro dimensionale dalle fattezze del viaggio. Quello dell'Io più nascosto. Quello, insomma, o che almeno lo rasentava da molto vicino, che Melanie Klein definiva come una sorta di Io Rudimentale già presente nelle prime fasi dello sviluppo della personalità umana e che, poi, avrebbe contribuito a svilupparla sulle contrapposizioni fra Io Arcaico e Super Io Arcaico - amore - odio, libido - pulsioni distruttive. E di distruttivo leggo. Perché spesso un libro è così forte da avere un impatto al limite della distruzione, di tutto quell'apparato sovrastrutturale che il limite dell'età ed il tempo a disposizione hanno contribuito a costruirci addosso. E noi quasi lo indossiamo. Come fosse una tenuta mimetica ed i pensieri in continuo assetto di lotta. Ma la parola ha, anche, la forza della lotta, è spesso un dono - come scriveva tempo fa Mauro Marino su L'Ultima de Il Paese Nuovo «Dono! Dono! Soltanto dono! Che parola di rivolta!» - ed in questo suo essere un dono assume, oggi, in un contesto globalienizzato dal capitalismo imperante, la condizione che è propria della rivolta. E nella rivolta si annidano forza. Ma anche dolore. Ed a volte la parola non è solo un immaginario, ma così legata al terreno da essere lei. Soltanto lei. La parola. Radice pura scalfita solo dal dolore. "Fatti di dolore" di Maurizio Nocera ci porta nella condizione poietica di un testo in cui l'utilizzo della parola si lega al vissuto quotidiano di un uomo, un autore, che della parola ha fatto veicolo espressivo in cui essa è la realtà e non la rifugge. Ma la affronta memore della rivoluzione. Perché è parola sulle corde della poiesis e la praxis aristoteliche. Affermava Aristotele, infatti, che «Chiunque produce qualcosa la produce per un fine, e la produzione non è fine a se stessa (ma è relativa ad un oggetto, cioè è produzione di qualcosa), mentre, al contrario, l'azione morale è fine in se stessa, giacché l'agire moralmente buono è un fine, e il desiderio è desiderio di questo fine»(Aristotele, Ethica nicomachea). Fatti di dolore è desiderio di questo fine, di una poiesis misurata all'agire tecnico/pratico della praxis come valvola di sfogo finale del desiderio, in una sorta di pointing vigotskyano in cui oggetto è il desiderio indicato - in un tentativo a vuoto d'essere afferrato - dalle ferite dell'Io, e che viene soccorso dalla commistione fra poiesis e praxis che, in un gesto di parole, afferrano il desiderio stesso che è quello del raccontare, in versi, rendere omaggio alla madre morta, stabilendo un ultimo tentativo di ritorno alla figura materna, tanto cara all'autore, così come è cara (pur subendo l'influsso delle pulsioni contrapposte secondo la dottrina Kleiniana) all'io bambino dell'uomo. Pubblicato per la prima volta nel 2002 «in un'edizione alla macchia» - dice l'autore - riportando, fra l'altro, le lettere di Mario Marti, Ennio Bonea, Donato Valli e la prefazione di Mario Geymonat, ripubblicato nel 2005 dall'editore Tallone di Alpignano (Torino) in 103 copie, edizioni per bibliofili, con, ancora, la prefazione di Mario Geymonat ed una postfazione di Sergio Vuskovic Rojo. Nel 2009 il testo viene ristampato, fuori collana, per i quaderni "I Poeti de «L'Uomo e il Mare»" in 300 esemplari, con postfazione dell'autore stesso.
Ho sempre pensato alla parola, per così rivolgermi ad essa, come un immaginario, un raccontare per immagini spesso staccato da terra. E lì, mi dicevo, affossare un po' tutto. Una visione che al tempo stesso era del mondo e staccata da esso, perché lontana da terra, incastonata in un quadro dimensionale dalle fattezze del viaggio. Quello dell'Io più nascosto. Quello, insomma, o che almeno lo rasentava da molto vicino, che Melanie Klein definiva come una sorta di Io Rudimentale già presente nelle prime fasi dello sviluppo della personalità umana e che, poi, avrebbe contribuito a svilupparla sulle contrapposizioni fra Io Arcaico e Super Io Arcaico - amore - odio, libido - pulsioni distruttive. E di distruttivo leggo. Perché spesso un libro è così forte da avere un impatto al limite della distruzione, di tutto quell'apparato sovrastrutturale che il limite dell'età ed il tempo a disposizione hanno contribuito a costruirci addosso. E noi quasi lo indossiamo. Come fosse una tenuta mimetica ed i pensieri in continuo assetto di lotta. Ma la parola ha, anche, la forza della lotta, è spesso un dono - come scriveva tempo fa Mauro Marino su L'Ultima de Il Paese Nuovo «Dono! Dono! Soltanto dono! Che parola di rivolta!» - ed in questo suo essere un dono assume, oggi, in un contesto globalienizzato dal capitalismo imperante, la condizione che è propria della rivolta. E nella rivolta si annidano forza. Ma anche dolore. Ed a volte la parola non è solo un immaginario, ma così legata al terreno da essere lei. Soltanto lei. La parola. Radice pura scalfita solo dal dolore. "Fatti di dolore" di Maurizio Nocera ci porta nella condizione poietica di un testo in cui l'utilizzo della parola si lega al vissuto quotidiano di un uomo, un autore, che della parola ha fatto veicolo espressivo in cui essa è la realtà e non la rifugge. Ma la affronta memore della rivoluzione. Perché è parola sulle corde della poiesis e la praxis aristoteliche. Affermava Aristotele, infatti, che «Chiunque produce qualcosa la produce per un fine, e la produzione non è fine a se stessa (ma è relativa ad un oggetto, cioè è produzione di qualcosa), mentre, al contrario, l'azione morale è fine in se stessa, giacché l'agire moralmente buono è un fine, e il desiderio è desiderio di questo fine»(Aristotele, Ethica nicomachea). Fatti di dolore è desiderio di questo fine, di una poiesis misurata all'agire tecnico/pratico della praxis come valvola di sfogo finale del desiderio, in una sorta di pointing vigotskyano in cui oggetto è il desiderio indicato - in un tentativo a vuoto d'essere afferrato - dalle ferite dell'Io, e che viene soccorso dalla commistione fra poiesis e praxis che, in un gesto di parole, afferrano il desiderio stesso che è quello del raccontare, in versi, rendere omaggio alla madre morta, stabilendo un ultimo tentativo di ritorno alla figura materna, tanto cara all'autore, così come è cara (pur subendo l'influsso delle pulsioni contrapposte secondo la dottrina Kleiniana) all'io bambino dell'uomo. Pubblicato per la prima volta nel 2002 «in un'edizione alla macchia» - dice l'autore - riportando, fra l'altro, le lettere di Mario Marti, Ennio Bonea, Donato Valli e la prefazione di Mario Geymonat, ripubblicato nel 2005 dall'editore Tallone di Alpignano (Torino) in 103 copie, edizioni per bibliofili, con, ancora, la prefazione di Mario Geymonat ed una postfazione di Sergio Vuskovic Rojo. Nel 2009 il testo viene ristampato, fuori collana, per i quaderni "I Poeti de «L'Uomo e il Mare»" in 300 esemplari, con postfazione dell'autore stesso. Il desiderio, dicevo, assume i connotati che sono propri delle parole in quel tentativo di ricongiungersi alla madre come quando si è bambini, un tentativo di riunirsi alla "mancanza" e che emerge ancor più forte nelle parole della postfazione dell'autore all'edizione del 2009 e che recitano così «la mamma [...] più volte ci faceva ripetere questa strofa, che forse appartiene ad un salmo e che io non ho dimenticato più: L'eterno riposo dona loro, o Signore/ e splenda ad essi la luce perpetua:/ riposino in pace. Amen." Da quando la mia mamma volò via per sempre verso i cieli del mistero, non so per quale recondita piega del mio inconscio, il ritornello mi torna spesso in mente, quasi sempre in certi particolari momenti della giornata, ad esempio quando sto lavando i piatti, oppure quando sto facendo il bucato...». Ed ha ragione Maurizio Nocera ad affermare che il motivo per cui quei versi tornano alla sua memoria in quei particolari momenti affonda le proprie radici nella sua infanzia - dunque in quelle pulsioni dell'inconscio che a contatto coi gesti che un tempo furono della madre ritornano più forti a spodestare l'odio dall'opposizione delle pulsioni amore-odio, nel trionfo finale dell'amore per la madre che sfocia nella delicatezza esterna/interna delle parole. Compianto, è il poema di Maurizio Nocera in cui ripercorre gli ultimi giorni della madre in un’alternanza di continui flash che si aprono come intermezzi ritmici dei ricordi dell’autore bambino, scanditi e interrotti anch’essi dai ricordi dell’autore adulto, di quegli ultimi giorni e del dolore che «Come un fulmine è stata la violenza del colpo al cuore innamorato». Sono i tempi di una vita passata che scanditi attraverso le parole rivivono nell’ora del quotidiano trasporto emozionale dell’autore, emersi dall’inconscio si legano stretti all’ora fra le pieghe di un poema che odora di tutto un percorso di una vita. La parola, dicevo in apertura, si manifesta nella scrittura dell’autore con solennità, imponente. È radicata. Ha la forza di un macigno. Ma c’è qualcosa che fende l’aria. E ancor di più l’anima. E se la parola è pur sempre un macigno sulla strada, fra le pagine misurate dalla vista dei nostri occhi, c’è qualcosa che trascende la dimensione stessa del testo. È il pathos, in ultima istanza, a rappresentare lo sfondo dell’opera, la grecità mai sopita di una terra, la nostra, che nell’eterno della tragedia trae linfa dal pathos.
Francesco Aprile
2010/09/02