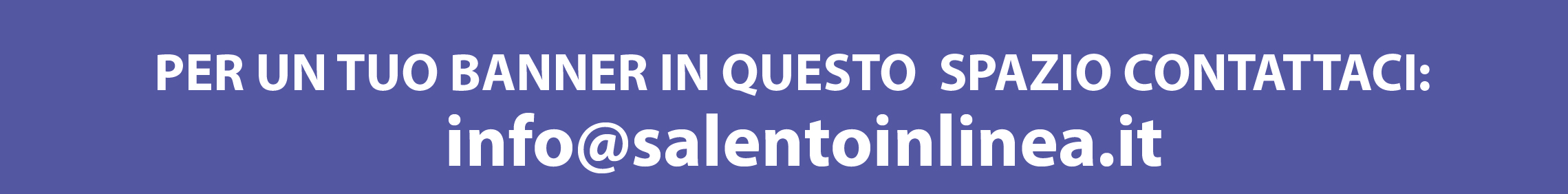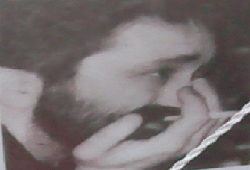 La salle de bain, giovedì 16 febbraio presso il Teatro Paisiello di Lecce, è uno spettacolo di Fabio Tolledi per Astragali Teatro che rende omaggio all'autore Antonio Leonardo Verri.Ore 21:00. Ingresso 5 euro.
La salle de bain, giovedì 16 febbraio presso il Teatro Paisiello di Lecce, è uno spettacolo di Fabio Tolledi per Astragali Teatro che rende omaggio all'autore Antonio Leonardo Verri.Ore 21:00. Ingresso 5 euro.
Verri scrive. Monta. Gonfia il testo. Organizza le parole secondo l'ordine del caos, di un suo attento calcolo, come manovrazione sistematica del verso, del tempo, del ritmo, dello scorrere in sé delle parole lanciate sulle pagine del vivere. Dello scrivere puro. Denso. Pieno. Ricolmo di sé e di ciò che è stato. In piena consapevolezza. Cattura la parola. Ma sono codici che, nella sua scrittura, si traducono come una sorta di pastiche ideologico-letterario di sistemi linguistici - in pieno accordo, dunque, col postmoderno - provenienti da altre sfere, stimoli ed echi dada-surrealisti, statunitensi direttamente dalle strade della Beat Generation (si pensi ai Kerouac e Ginsberg ampiamente citati nelle pagine de Il Pane sotto la neve ed ai riferimenti, più o meno scoperti, delle operazioni linguistiche del Verri di "La Betissa", dell'invenzione pura della parola in quel suo rimando al Kerouac de "I Sotterranei" nell'esposizione del gergo "nuovo" dello statunitense), "dall'Officina" della parola di Raymond Queneau, dall'italico Consolo, dal silenzio di John Cage, dalle sonore ripetizioni del "battito creatore" di Francesco Saverio Dòdaro. E si realizza in un pastiche concettuale delle tecniche di scrittura più affini, vicine, al suo sentire letterario, e si realizza, l'invenzione, nell'aspetto concettuale dei paradossi della scrittura, nei paradossi propri, anche, dei Trofei della città di Guisnes, che pure si muove, la scrittura, attraverso il sapiente uso dei sistemi letterari della ricerca del '900 verso orizzonti che si materializzano come spiazzanti, diversi, per estremità del verso, per inflazione dell'informazione che sembra "scadere" nel nulla dei significati causa bombardamento di parole che, invece, si riappropriano di una portata semantica a sé, che sa di nuovo, perché figlia del sapiente mescolare intrecci scritturali di matrici ed esperienze opposte. La scrittura, dunque, come mezzo polivalente, emblematico. Sublime. La scrittura come il macinare dei chilometri, il coprire le distanze fra uomini e uomini, mondi e mondi. Le parole come mondo unico, ponte eterno fra culture diverse. Tratteggiare la pratica poetica di Antonio Verri significa avventurarsi in un magma pronto ad esplodere in qualsiasi momento. È proprio dell’esplosione che ogni parola si compone. Dire di parole che sono chilometri, nazioni, mondo, persone. La pratica poetica di Verri ci impone un discorso di universalità. È nella narrazione mondo che sfolgora il ritmo di una nuova repubblica del linguaggio che si costruisce pensando al futuro, macinando il passato. È nella narrazione mondo, sulla falsariga di un Kerouac che vedeva nei suoi romanzi il libro unico in cui racchiudere la sua storia, così Verri compone una prosa che è poiesi che a sua volta ha il sapore di continui ritorni, rifrazioni, di frammenti, di pezzi, di specchi, di oggetti che sono parole che sono echi dello scrittore stesso e tornano in maniera ciclica all'interno di un testo stesso e, ancora, di volta in volta, di libro in libro, amplificati. È nell'estremo che monta il testo. E nel margine si trattiene. E Verri affronta per mezzo del linguaggio un suo primo sdoppiarsi nella decisione delle parole. Un suo primo rifrarsi sullo specchio immacolato della poesia, scendere al confronto di un freudiano miroir per accedere alla chiave di un ritorno a sé, primordiale, per riabbracciarsi nella sua interezza. In un gioco di riflessioni che è una sorta di autoipnosi per entrare in uno stato di trance e raccontarsi, scriversi su carta, farsi carne, ancora per essere un'altra volta nascita. Assimila le sue stesse parole, le assorbe, ma è come se le parole assimilassero l’autore. La scrittura è un vortice che in Verri si esplicita come un travolgersi a vicenda fra testo e ricerca personale. In quel suo continuo cercarsi nello specchio e fingersi, ora lo specchio ora se stesso, ora verso unico fra le pagine dei suoi testi. E ricondursi al rapporto freudiano di un transfert, porsi, così, nella condizione d'essere lui bambino davanti al genitore, il Verri adulto, al quale raccontare "quei sogni accorti" trafugati allo specchio. La ricerca di sé per forza di cose parte dal passato, lo specchio nel quale frugare se stessi e l'esperienza linguistica come, ad esempio, quella d'intrecciare le proprie vicende con quelle del Galateo è necessità, stimolo, forza, unione e dissolvimento nel quale ricercare e proiettarsi nel futuro. Ripercorre le vicende del Galateo lasciando che sia il Galateo stesso a parlare attraverso le parole di Verri, e viceversa, così da creare una dimensione unica fra passato e presente unita dall’incontrarsi e unirsi delle storie di Verri e del Galateo, nel gioco letterario che Verri crea partendo dall'immagine dialettica di Walter Benjamin, che solo nel linguaggio si può esprimere e solo nel linguaggio essa si può illuminare, in quel punto in cui il passato (il Galateo) incontra l'istante (il presente Verriano) e generano il futuro, ciò si fa gioco necessario alla costruzione di una lingua che è forza ed unione di un mescolare che lo stesso autore lascia volutamente, a mio avviso, al montare del caos, senza concedere una forma definitiva proprio in quel percorso conclusivo che è rappresentato da Bucherer l'orologiaio, in quel limbo dell'indeterminato che somma il ribollire continuo delle parole allo straniamento del lettore ipnotizzato e arreso dal moltiplicarsi dei significati. Ed emblema di questo abbandono al "montare" è il continuo incastrarsi delle parole in un sommovimento degli spazi vuoti delle pagine, dei paradossi dei Trofei della città di Guisness dove partiva, dopo anni di "ricognizioni" nel testo, dal surreale primitivismo per oltrepassarlo e realizzare una nuova condizione di primitivismo traslando la condizione primigenia dell’uomo nel paradosso che lui stesso aveva creato, la metropoli nella realtà contadina del Salento – inserendo motivi propri della ricerca musicale di John Cage, di quel silenzio del compositore che per l'autore di Caprarica di Lecce diventava il realizzarsi in terra salentina di una situazione ad essa estranea, la Metropoli - tramutando la figura dell’uomo selvaggio in quella del poeta, unico capace d'ascoltare l'oscillare del tempo, di un Salento e delle sue evoluzioni sociali innestate su di un "ordigno" pronto a gettarsi nel futuro (Guisness, la metropoli, le parole), ma che vedeva, ancora, un presente in bilico costante fra un superamento del tempo ed un passato che non era mai passato, ma sempre presente ancorato a culti e magie.
Francesco Aprile