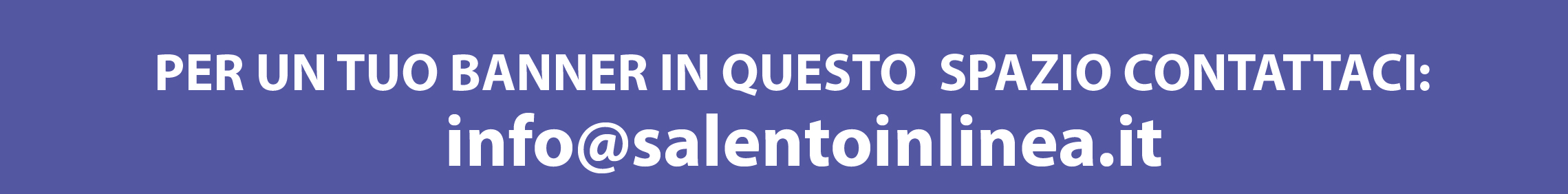Nella ricerca svolta da Maurizio Nocera in “Il morso del ragno. Alle origini del tarantismo” (Capone Editore) vengono individuate tutta una serie di tarantelle sviluppate nel Sud Italia e, anche, in Toscana. La ricerca si sofferma ed analizza il fenomeno che a noi interessa molto da vicino, ovvero, il Tarantismo Salentino, il fenomeno della Pizzica. A pagina 6 del libro “Il Morso del Ragno” è lo stesso Nocera a scrivere «Il fenomeno, inteso come ritmo terapeutico, si poneva come uno dei tanti modi naturali di liberazione dalle energie negative del corpo.»
Nella ricerca svolta da Maurizio Nocera in “Il morso del ragno. Alle origini del tarantismo” (Capone Editore) vengono individuate tutta una serie di tarantelle sviluppate nel Sud Italia e, anche, in Toscana. La ricerca si sofferma ed analizza il fenomeno che a noi interessa molto da vicino, ovvero, il Tarantismo Salentino, il fenomeno della Pizzica. A pagina 6 del libro “Il Morso del Ragno” è lo stesso Nocera a scrivere «Il fenomeno, inteso come ritmo terapeutico, si poneva come uno dei tanti modi naturali di liberazione dalle energie negative del corpo.»Alla base della Pizzica è possibile individuare elementi contraddittori che, allo stesso tempo, sanno farsi complementari. Ed è proprio questo loro esistere allo stesso tempo, in contraddizione, nell’uomo a generare il fenomeno del Tarantismo.
Alla base del fenomeno, la genetica (come genesi e altro ancora da sviluppare, ma non in questa sede) della transe. Uno stato di dissociazione psichica che Jung fa derivare dall'eventuale squilibrio che in un soggetto si viene a creare fra elementi della storia individuale ed elementi appartenenti a quella storia inconscia dell'umanità codificati come archetipi, modelli ideali. Modello che viene identificato come archetipo è, in questo caso, il mito del ragno, che assume in epoche del tutto recenti una doppia connotazione, venendo messo in relazione, spesso, con l'aspetto religioso espresso attraverso la figura di San Paolo. Aspetti contrastanti alla base della crisi che si fa liberatoria nella transe dei tarantati come evento catartico. Proprio come avviene nel brano della tradizione salentina "Santu Paulu" che si conclude con "Ci è taranta lassala ballare/ci è malincunia cacciala fore" a "cacciare" fuori il male di vivere attraverso l'atto del ballo. Ma la ripetizione ossessiva del ballo è strumento stesso per la catarsi e per il raggiungimento della transe come avveniva in Cina, diciotto secoli prima di Cristo, attraverso balli e canti ripetitivi che portavano alla transe, e ancora i profeti di Baal che saltavano per ore attorno all'altare, o l'insistente ripetizione delle nenie da parte dei Druidi fino alle moderne tecniche di ipnosi che dalla ripetizione fissa di alcune parole o alcuni gesti portano alla transe ipnotica provocando una crisi nel soggetto ipnotizzato.
L’animale che contraddistingue tutto ciò è il ragno e nell’analisi di Nocera ci si spinge fino all’estremo, all’origine, realizzando un punto d’unione fra l’Oistros greco e la puntura del ragno che si fa estro, istigazione, possessione ed il ritmo della musica assume un ruolo catartico, liberatorio. Da qui, nasce il valore terapeutico del Tarantismo. Il Ragno/Oistros col suo morso arriva a possedere il corpo, scrive Nocera, «la possessione di un corpo da parte del ragno, sta a rappresentare le difficoltà della vita».
Interessante è la citazione che Nocera fa dal “De Sensu Rerum et Magia” di Tommaso Campanella, Francoforte 1620, in cui Campanella scriveva «I Tarantolati espellono il veleno del ragno attraverso il sudore causato dal ballo, generato, a sua volta, dal ritmo della musica» ad indicare come fosse ormai assunto il potere terapeutico/liberatorio del ballo dei tarantolati.
Ancora Maurizio Nocera da "Il Morso del Ragno" ci fa notare che "Si impossessa - offendendolo (morso e ri-morso) col suo oistros di un corpo di individuo, contrapponendosi inevitabilmente ad una divinità quale era l'Atena del mondo greco e la Minerva nell'antichità. [...] La gente del Salento, in generale, ha una venerazione particolare per la Vergine (Aracne è una giovane vergine) e allo stesso tempo per la Grande Madre (Atena-Minerva è allo stesso tempo la vergine per eccellenza, ma anche una Grande Madre androgina). Probabilmente questa credenza archetipale affonda le sue radici nelle età più remote, fino ad arrivare forse al neolitico e fors'anche al paleolitico salentino. Le Veneri di Parabita (paleolitico) e il pittogramma della Grande Madre Tridattile nella Grotta dei Cervi di Porto Badisco, stanno forse ad indicare qualche origine di questa struttura di credenze tra i locali".
 Esempio di questa serie di elementi contrastanti è l'iconografia dell'affresco di San Paolo a Patù, Cento Pietre, dove il Santo è raffigurato con in mano la spada attorno alla quale sono avvolti due serpenti ed alla sinistra del dipinto si trova un caduceo (prima simbolo di Mercurio, poi, ricondotto alla figura di Ermete Trismegisto); sono inoltre rappresentati il rospo, lo scorpione ed il ragno. Il ragno che, come detto, Nocera fa risalire al mito di Aracne narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, ma risalente ad epoca greca, in cui la giovane vergine Aracne, abilissima nel tessere, osò sfidare la dea Atena tanto che quest'ultima offesa dal comportamento della giovane la trasformò in un ragno obbligandola a filare dalla bocca per tutta la vita. Se a questo aggiungiamo l'ipotesi lanciata da Nocera secondo cui è possibile ipotizzare che il culto della Vergine fosse, anche qui nel Salento,
Esempio di questa serie di elementi contrastanti è l'iconografia dell'affresco di San Paolo a Patù, Cento Pietre, dove il Santo è raffigurato con in mano la spada attorno alla quale sono avvolti due serpenti ed alla sinistra del dipinto si trova un caduceo (prima simbolo di Mercurio, poi, ricondotto alla figura di Ermete Trismegisto); sono inoltre rappresentati il rospo, lo scorpione ed il ragno. Il ragno che, come detto, Nocera fa risalire al mito di Aracne narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, ma risalente ad epoca greca, in cui la giovane vergine Aracne, abilissima nel tessere, osò sfidare la dea Atena tanto che quest'ultima offesa dal comportamento della giovane la trasformò in un ragno obbligandola a filare dalla bocca per tutta la vita. Se a questo aggiungiamo l'ipotesi lanciata da Nocera secondo cui è possibile ipotizzare che il culto della Vergine fosse, anche qui nel Salento,  risalente al neolitico o addirittura al paleolitico come culto della Grande Madre, della Terra, della Fertilità, in virtù di antiche civiltà pre-istoriche di struttura matriarcale si inserisce, ciò - in questa mia ipotesi - in quel concetto di archetipi come elementi della storia inconscia - secondo la definizione di Jung - che vanno a contribuire al contrasto, allo squilibrio, in un dato periodo ed in una serie di persone, in quel contesto cristiano per cui si realizza un sovvertimento del paradigma tramutando la pre-istorica civiltà matriarcale in una società cristiana patriarcale; in virtù di questo è possibile pensare ad elementi di contrasto che rompono l'equilibrio psichico nell'uomo, in quanto estenuante accavallamento fra vecchio paradigma - assimilato come archetipo - e nuovo paradigma che cerca e si è cercato di imporre - e viene e si è imposto - su quei criteri inconsci che regolano lo sviluppo "genetico" dell'uomo. Il contrasto che si realizza nello spostamento sostituzione dell'archetipo contribuisce o genera l'elemento di rottura, di squilibrio, come concezione, il tarantismo, che ad esso si lega, si viene a generare nell'elemento di rottura del nuovo paradigma patriarcale che sovrapponendosi a quello matriarcale genera squilibrio, rottura inconscia nelle generazioni e società a venire.
risalente al neolitico o addirittura al paleolitico come culto della Grande Madre, della Terra, della Fertilità, in virtù di antiche civiltà pre-istoriche di struttura matriarcale si inserisce, ciò - in questa mia ipotesi - in quel concetto di archetipi come elementi della storia inconscia - secondo la definizione di Jung - che vanno a contribuire al contrasto, allo squilibrio, in un dato periodo ed in una serie di persone, in quel contesto cristiano per cui si realizza un sovvertimento del paradigma tramutando la pre-istorica civiltà matriarcale in una società cristiana patriarcale; in virtù di questo è possibile pensare ad elementi di contrasto che rompono l'equilibrio psichico nell'uomo, in quanto estenuante accavallamento fra vecchio paradigma - assimilato come archetipo - e nuovo paradigma che cerca e si è cercato di imporre - e viene e si è imposto - su quei criteri inconsci che regolano lo sviluppo "genetico" dell'uomo. Il contrasto che si realizza nello spostamento sostituzione dell'archetipo contribuisce o genera l'elemento di rottura, di squilibrio, come concezione, il tarantismo, che ad esso si lega, si viene a generare nell'elemento di rottura del nuovo paradigma patriarcale che sovrapponendosi a quello matriarcale genera squilibrio, rottura inconscia nelle generazioni e società a venire. Francesco Aprile