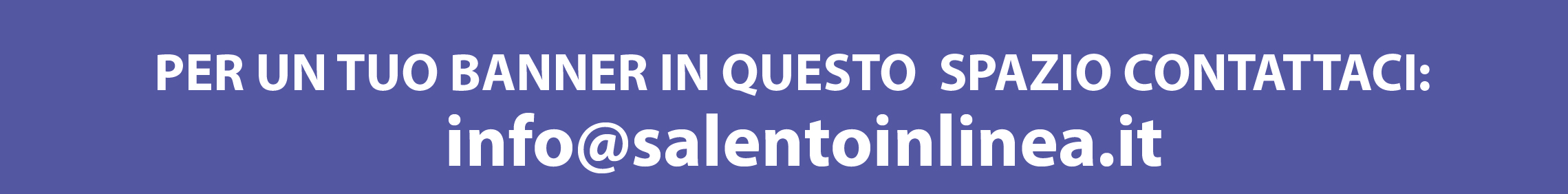«Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna». Vabbè, lo sappiamo (quasi) tutti, è un passo tra i più salienti del lungo carme dei Sepolcri con cui quel mattacchione di Ugo Foscolo, nel 1807, volle dare forza consolatoria agli estinguendi (noi) in vista dell’orizzontalità perenne che ci attende. Questo frammento lirico fa il paio con l’altro, sempre negli stessi Sepolcri, quello evocante la «corrispondenza d’amorosi sensi» che, per un attimo, fa pensare ad una novella del Boccaccio, ovviamente del Decamerone; in realtà è tutt’altro dacché quella corrispondenza bilaterale riguarda i vivi e i morti nel muto rapporto endofasico pertinenza dei primi. Per i secondi, i morti, ove ancora senzienti, vale di più il primo stralcio dove, pur defunti, in virtù di gesta Affettivamente commendevoli perpetrate in vita dovrebbero provare gioia ad essere rammentati da chi, ancora, trapassato non è. Reduce da una sequela di cerimonie funebri ravvicinate mi sono venute in mente queste amene considerazioni. In realtà, a consolarmi per le adunate funeralizie, in genere in orario tale da farmi saltare la pennichella, c’è l’amicale ritrovo dei convenuti, noti e ignoti, ormai attempati. Bello rivedersi tra chi si conosce e non si vedeva da tempo, sul sagrato della chiesa. Già, la Chiesa (questa volta col maiuscolo dovuto all’istituzione): ti aspetta al collo dell’imbuto e, pur se in vita ti sei professato ateo, sarà lei a celebrare il rito e i congiunti sorvoleranno sul passato miscredente del proprio de cuius consegnandolo al prete officiante. Il morto, comune punto di repere degli astanti, su quel sagrato viene ricordato ma non mancheranno le digressioni, si passerà a rimembranze di vario genere che man mano rompono il ghiaccio sino a generare scrosci di risa irriverenti, per la circostanza, in ossequio all’adagio che recita «non c’è funerale senza risa come non c’è matrimonio senza pianti». Il defunto, se lo è stato (e lo è rimasto), intelligente, non si adonterà per questo cambio di registro umorale nel giorno del suo commiato oppure mediterà rivalse violando i nostri spazi onirici. Il dubbio ci passa, ma è un attimo. La campanella come nei foyer del teatro richiama e la messa inizia, la bara, quel conchiuso di non più vita troneggia ai piedi dell’altare, talvolta reca la foto del suo miglior contenuto. Si trova posto tra gli scranni, i primi destinati ai familiari, coloro che piangono davvero, negli ultimi, pur se c’è posto davanti, vi si metteranno quelli che hanno già salutato prima, li hanno visti, e potranno dissolversi prima della fine del cerimoniale. Tuttavia, è il momento della serietà, ci si ricompone, i visi si fanno compunti, perfino ieratici. La formula liturgica è quella, ripetitiva, sappiamo che al Paternoster siamo più o meno a metà del rito, che mai ci appassiona, intervallato dagli «in piedi» e «seduti» che come pistoni di uno stanco diesel ci fa muovere le giunture. Al momento dell’omelia il sacerdote ci parla del defunto, anche se non lo ha conosciuto né mai l’ha visto; chiederà qualche fugace notizia ai parenti prossimi per riportarla al meglio nella predica, oppure, se questi era dedito a frequentare tanto meglio, per il prete. Ci troveremo sempre alla descrizione di una persona dalle rare virtù, spesso eccezionali, qualcuno dei presenti sa che, magari, non è esattamente così ma la morte è un lavacro per tutti. Amnistia. Prima di andare in pace, come il sacerdote ammonisce, ci sarà la coda per salutare i parenti, frastornati da quei subitanei baci e abbracci, che ebbero tregua ai tempi del Covid e ora ripristinati. I parenti stretti e gli intimi (se lo vorranno) proseguiranno sino al Camposanto, tutti gli altri alle loro opre. La vita continua. Alla prossima.
«Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna». Vabbè, lo sappiamo (quasi) tutti, è un passo tra i più salienti del lungo carme dei Sepolcri con cui quel mattacchione di Ugo Foscolo, nel 1807, volle dare forza consolatoria agli estinguendi (noi) in vista dell’orizzontalità perenne che ci attende. Questo frammento lirico fa il paio con l’altro, sempre negli stessi Sepolcri, quello evocante la «corrispondenza d’amorosi sensi» che, per un attimo, fa pensare ad una novella del Boccaccio, ovviamente del Decamerone; in realtà è tutt’altro dacché quella corrispondenza bilaterale riguarda i vivi e i morti nel muto rapporto endofasico pertinenza dei primi. Per i secondi, i morti, ove ancora senzienti, vale di più il primo stralcio dove, pur defunti, in virtù di gesta Affettivamente commendevoli perpetrate in vita dovrebbero provare gioia ad essere rammentati da chi, ancora, trapassato non è. Reduce da una sequela di cerimonie funebri ravvicinate mi sono venute in mente queste amene considerazioni. In realtà, a consolarmi per le adunate funeralizie, in genere in orario tale da farmi saltare la pennichella, c’è l’amicale ritrovo dei convenuti, noti e ignoti, ormai attempati. Bello rivedersi tra chi si conosce e non si vedeva da tempo, sul sagrato della chiesa. Già, la Chiesa (questa volta col maiuscolo dovuto all’istituzione): ti aspetta al collo dell’imbuto e, pur se in vita ti sei professato ateo, sarà lei a celebrare il rito e i congiunti sorvoleranno sul passato miscredente del proprio de cuius consegnandolo al prete officiante. Il morto, comune punto di repere degli astanti, su quel sagrato viene ricordato ma non mancheranno le digressioni, si passerà a rimembranze di vario genere che man mano rompono il ghiaccio sino a generare scrosci di risa irriverenti, per la circostanza, in ossequio all’adagio che recita «non c’è funerale senza risa come non c’è matrimonio senza pianti». Il defunto, se lo è stato (e lo è rimasto), intelligente, non si adonterà per questo cambio di registro umorale nel giorno del suo commiato oppure mediterà rivalse violando i nostri spazi onirici. Il dubbio ci passa, ma è un attimo. La campanella come nei foyer del teatro richiama e la messa inizia, la bara, quel conchiuso di non più vita troneggia ai piedi dell’altare, talvolta reca la foto del suo miglior contenuto. Si trova posto tra gli scranni, i primi destinati ai familiari, coloro che piangono davvero, negli ultimi, pur se c’è posto davanti, vi si metteranno quelli che hanno già salutato prima, li hanno visti, e potranno dissolversi prima della fine del cerimoniale. Tuttavia, è il momento della serietà, ci si ricompone, i visi si fanno compunti, perfino ieratici. La formula liturgica è quella, ripetitiva, sappiamo che al Paternoster siamo più o meno a metà del rito, che mai ci appassiona, intervallato dagli «in piedi» e «seduti» che come pistoni di uno stanco diesel ci fa muovere le giunture. Al momento dell’omelia il sacerdote ci parla del defunto, anche se non lo ha conosciuto né mai l’ha visto; chiederà qualche fugace notizia ai parenti prossimi per riportarla al meglio nella predica, oppure, se questi era dedito a frequentare tanto meglio, per il prete. Ci troveremo sempre alla descrizione di una persona dalle rare virtù, spesso eccezionali, qualcuno dei presenti sa che, magari, non è esattamente così ma la morte è un lavacro per tutti. Amnistia. Prima di andare in pace, come il sacerdote ammonisce, ci sarà la coda per salutare i parenti, frastornati da quei subitanei baci e abbracci, che ebbero tregua ai tempi del Covid e ora ripristinati. I parenti stretti e gli intimi (se lo vorranno) proseguiranno sino al Camposanto, tutti gli altri alle loro opre. La vita continua. Alla prossima.