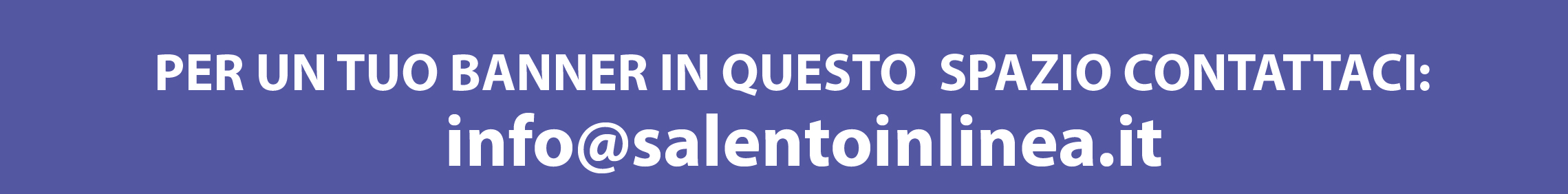Tra parola detta, scritta e gestualizzata
di Francesco Pasca
Non sarà certo in questa sede che si possono risolvere i problemi del linguaggio, qualora ve ne siano di seguito tracciati, ma, avendone io la mira di discuterne, ne approfitto per il particolare interesse che suscita il discorrere di questo sulle pagine di “Cultura”. In questi giorni si è svolta un’interessante rassegna presso il Fondo Verri di due giovani presenze nel campo del linguaggio. 16 i testi di Teresa Lutri e 14 quelli di Francesco Aprile. Sono due presenze di segno scritto che hanno ormai gambe per camminare da sole e non essere più megafoni di alcuno. Quel che interessa è la rielaborazione del sistema di punteggiatura oggi in uso. Apparato pausativo così amano definirlo. Un riepilogo della punteggiatura e sua sintassi richiamata dalla prosa spontanea ed in un continuum fra oggetto e corpo nella definizione di: «fra nervi carne e muscoli del corpo. Il corpo. Oltre il punto.» Tre interpunzione secche private della loro logica di “soggetto predicato complemento e poi il punto”.
Un altro formarsi di linguaggio interessante è apparso sulle stesse pagine de “ilPaeseNuovo”, quotidiano salentino, in un titolo recitato: ” Fra identità inventate e (in)coscienza d’essere”, riferite ai Tarantismi pre-meditati con un colore pop alla Andy Warhol ed in un testo di Federico Capone. Ho ravvisato un’identità culturale interessante anche per un altro fenomeno, quello della diffusione di un linguaggio sonoro-gestuale in una musica di Terra d’Otranto. Se ne potrà parlare in seguito riconducendolo ad altre totalità simultanee.
In queste presenze ancestrali di “oltre il punto” e di “(in)coscienza d’essere”, essendo un ondivago del gesto ai primordi, non posso che affiancare anche il mio vagabondare dal suono all’immagine nei primordi e viceversa. Pertanto è del linguaggio, di uno in particolare, che voglio parlare. Desidero poter descrivere quello relativo all’uso dell’onomatopea o meglio del suono fra segno ed immagine.
Dal triangolo di Ogden e Richards, la definizione di una "creazione di un nome" è il risultato di una parola in un sistema linguistico. La Singlossia è uno di questi termini, una creazione di nome, l’intento di una nominazione. Questo intento, come in tutti i vocaboli, è riconducibile all’espressione ed è composto da un significante e da un significato. L’idea che lo determina, e, che altrettanto ne deriva, è il rimando al referente. In questo caso è il suono. Si tratterebbe, quindi, di una "trascrizione di un suono", la cui connessione è tra significante e referente. Fin qua niente di eccezionale, tutto ricade nella norma e si riconduce alla pratica. Infatti il termine Singlossia è la congiunzione di una voce dotta composta tramite la preposizione greca ù - sin – e , dativo di - lingua – , e ne indica la sintesi visiva e sonora di un linguaggio visivo e verbale. Da ciò, qualunque sia la naturale connessione che si abbia fra oggetto e parola, questa non può appartenere che ad una sola piccola parte della fabbrica del Linguaggio.
Tra le idee della mente ed i suoni articolati, troverete sempre tale connessione e se ne vedrà sempre un sistema generale tra una siffatta connessione naturale ed una connessione fra parole ed idee. Ossia le diverse forme dei suoni articolati sono tra loro scelti per condurci, a farci comunicare un’idea.
Le espressioni delle nostre idee si esprimono dunque con il Linguaggio. Il mezzo praticato con certi suoni articolati, che si adoperano come segni, sono per l’appunto le stesse idee. Con questa precisazione intendo specificare i suoni emessi e s'intenderanno come le modificazioni, inflessioni, accenti della voce formati per mezzo della bocca e dei suoi vari organi, i denti, la lingua, le labbra ed il palato.
Applichiamo sempre e comunque un metodo artificiale per comunicare un’idea cercando di portarla sempre, con un adeguato linguaggio, alla più alta perfezione. Il mezzo linguaggio diventa così il veicolo.
Necessità, questa, per dar luogo ad una corretta interpretazione è l’assegnazione dei nomi da assegnare a tutti gli oggetti di cui amiamo circondarci, riconoscerne la forma. Tutte le relazioni e le differenze dei suoni articolati passano fra il riconoscere questi oggetti e i loro fonemi e, tanto più lo sono tra loro vicini, tanto più, di seguito, sono descritti dall’invisibile riconoscimento dell'animo. Si direbbe che questi riconoscimenti a noi si avvicinano e vengono resi altrettanto intelligibili.
Persino le possibili astrazioni sono e divengono le nozioni per riscoprire ed immaginare nuove creazioni ad esse relazionate, sono così trasmesse e trasfuse in un'altra immagine.
Hugh Blair scriveva nelle sue lezioni di retorica e belle lettere nel 1801: «Andavano gli uomini allora erranti e dispersi; non eravi società, fuorché quella di famiglia; e la società di famiglia era pure imperfetta, poiché il lor metodo di vivere colla coccia o la pastura delle gregge dovea frequentemente separarli l'uno dall'altro. In tale stato, mentr'erano gli uomini sì divisi, e sì raro il loro commercio, come mai alcuna forma di suoni o di parole potè fissarsi per generale accordo a significare le loro idee?»
Si evince l’impossibilità di una comunicazione conclusa, di una necessità a dar luogo ad una qualsiasi forma di linguaggio o in grado di poter intrattenere, qualora ne manchi l’aggregazione, con un nuovo iter.
L'onomatopea, per prima, non poteva, né ancor oggi può aver luogo se la trascrizione fonica di un qualsivoglia rumore non veniva, viene codificata attraverso i fonemi di un sistema linguistico, e, se ciò accadeva, accade, era nel solitario disbrigo della pratica della sopravvivenza o di una voce irraggiungibile. Qualsiasi "voce imitativa" o di "interiezione" era, è fra l’uomo errante e le sue cose. Il valore evocativo delle onomatopee era ed è l’emblematico risultato di un fatto accaduto.
Dal fatto, successivamente, poteva accadere il riporto. Dal riporto, la possibilità di una decodificazione. La figura assegnata al termine "romori" anziché "rumori", del termine (in)(personale) anziché impersonale (come derivazione di svuotamento del personale con la pratica della immissione-saturazione di un valore), la parola (mas[sa)cro] anziché o al posto di massacro o massa o sacro. L’ [(in)coscienza)] in cui una (in) di troppo non conduce all’errore-saturazione, ma alla restituzione di un valore, ed ancora il termine di [(Pecula)ri(età)] anziché di Peculiarità così come scritto in una NewPage.
A quell’idea s’appoggiava la somiglianza del suono con un altro suono, del segno con un fonema sempre più definito, diverso e collimante.
Nell’onomatopea, se il termine “cloppete” di Palazzeschi è stato appoggiato, riferito al coadiuvare ed è un suono, questo si arricchisce con la respirazione profonda e l’utilizzo del labbro. Mentre viene pronunciato il suono s’aggiunge ai denti, alla lingua, alle labbra ed al palato, lo si sostituisce con un costante sovrapporsi ed addizionarsi. Un modo semplice per ottenere una vera e propria Pluri-glossia è quanto, con la pioggia nel pineto d’Annunzio voleva creare per un effetto estetico; con quanto il Pascoli declamava nella poesia “Valentino“: «Un cocco! / ecco ecco un cocco un cocco per te!»; con quanto Apollinaire, nello strumento calligramma, aggiungeva ed otteneva in un effetto grafico in un rimando.
La Singlossia è dunque il riproporre un Palazzeschi, un Apollinaire o un Marinetti rinnovato nell’onomatopea con il diacronico.
É tutto questo e non altro.
É “La fontana malata” con il suo «Clof, clop, cloch,/cloffete,/cloppete,/(…)chchch …».
Si porta indietro per un attimo il Tempo, lo riportiamolo alla nascita pensiero (in)perfetto, all’origine del Suono-Parola. Ripercorriamo gli ostacoli e i processi.
Siamo ormai abituati ad assistere ai progressi scientifici e alle cosiddette invenzioni estetiche dell’arte, ma spesso accade di non renderci conto dei gradini, delle separazioni, dell’inizio e del fine (qui il termine “fine” è il “non fine ultimo”, lo stesso inizio).
Decidiamo quasi automaticamente di accettarlo come avvenimento dovuto. Se confrontiamo l’aspetto sintattico e morfologico in una frase pronunciata nei secoli addietro, (verificatelo con quanto ho riportato nel testo traduzione del Soave), e se, responsabilmente, ne siete predisposti, vi accorgerete, immediatamente, che si esamina la frase secondo la prospettiva del presente, eludendo così l’analisi sincronica. Vi accorgerete che l'oggetto parola è divenuto per voi così familiare, tanto comune, che lo guarderete-leggerete senza meravigliarvene.
In Arte, un Artista del nostro tempo, Christo Vladimirov Javašev di origine bulgara, nato a Gabrovo, ci ha dimostrato, con l’impacchettamento delle solenni Mura Aureliane a Roma ed in altri oggetti posti qua e là nel mondo, che il colore è un’intuizione totalmente diversa tanto da sembrare un mega oggetto d’arredo urbano o d’arredo planetario. Il Suo proposto stava e sta lì nell’immaginario a ricordarci che il tempo esiste ed è diacronico nei linguaggi; è l’identica cosa di un qualsiasi rumore anche se criptico o male interpretato.
I deboli principi li ha fatti divenire ostacoli e motivo di grandissimo stupore. Ci ha portato al mirare ed il tutto lo ha ricondotto all’origine.
Ora, con quale autorità poté propagarsi nelle tribù e nelle famiglie dell’uomo primitivo un linguaggio?
Parrebbe che, per fissare e propagare una Lingua, si ci dovesse, dapprima, raccogliere in un considerevole numero di uomini, e che la società, così costituita, si andasse via via a determinare in uno stadio molto avanzato di esperienza, e che quest’ultima divenisse luogo di comune interesse. Tutto l’iter per poter dar luogo al linguaggio e a comunicarsi i bisogni, soprattutto le idee.
Il suono, certamente, l’accomunava. I primi elementi di un linguaggio sono quindi suoni articolati. L'ipotesi, non nuova, e che l'origine della o delle lingue non siano state di origine divina (menomale). Anche il principio della socievolezza non è un principio “divino”, ma una necessità. È lo stesso Dio a dirlo (menomale), così come riferito nella Genesi. È detto, apertamente, che Dio abbia dato la facoltà di inventare un linguaggio iniziando con l’assegnazione dei nomi. Avremmo avuto quindi il primo “apparato pausativo”, la prima “(in)coscienza d’essere”, la prima "creazione di un nome", la conseguente nominazione privata dapprima del costrutto. Suppongo vi sia stato nella costruzione del linguaggio il suono come prima metafora della vita.
Da ciò il grido-rumore ed il timore, l’avvertimento, il segnale, l’interposizione, la favella onomatopeica come comunicazione, imitazione del suono del nome e della natura dell'oggetto nominato. Da lì il pittore graffitaro o petroglifa scultore per rappresentare le immagini adopererà il colore corrispondente all’oggetto; per rappresentare un segno o un volume adopererà la pietra. Suppongo non potesse fare altrimenti. Se amava far scaturire l'idea della cosa o nome che cercava d'esprimere, niente da allora fu arbitrario né senza alcun fondamento o ragione. Il supporre divenne un effetto da causa. L’immagine del morso del ragno e sue conseguenze sintetizzano egregiamente tutto questo e si fa benissimo oggi ad evocare, a capire cosa abbia indotto, induce a recepire un gesto associato in maniera diacronica ad un segno, ad un suono, ad un’idea.
Altrettanto è l’introduzione della sostituzione sistematica della punteggiatura classica con modalità di una perfetta propaggine del linguaggio corpo. Si pensi al gesto-suono-segno del maestro d’orchestra nell’indicare l’abbassare di un tono o il prolungamento di un suono in uno strumento. La pausa, l’annullamento o il prolungamento è, e diviene anche il segno di Francesco Aprile, l’uso dell’underscore (il trattino basso _ ).
La Singlossia è appena cominciata. Ricondursi all’origine attraverso il presente non è indietreggiare, ma trovare la forza di modificare il linguaggio, almeno quello derivabile dal triangolo di Ogden e Richards.
Stabilito che linguaggio è un sistema di comunicazione tra individui, quello che ancora deve essergli aggiunto è l’aggettivo affascinante, creativo, ed ancora che il linguaggio è tale e ne diviene se incrementato nella sua aggettivazione nel provare a definirlo, attuarlo come significato di un “Vero”, di Valore, di un’immagine da manipolare. Di questo e di tant’altro se ne può anche sorridere o storcere il naso, dissentire. Stabilire la trasmissione di un messaggio, sicuramente appartenente ad un linguaggio, è l’individuarne lo strumento per veicolare ed al contempo attuare la specificità di un’aspirazione, esigenza, è fargli compiere un determinato e preciso percorso. Esempio: consentire di penetrare in zolle sottili e segrete della sensibilità, proporlo come atto creativo e, predisporlo, non solo ad essere puramente iconico o fonico, ma duttile alla nostra interpretazione con l’intento di rigenerarsi nell’occasionale.
Non è presunzione? Se lo dovesse essere nell’affermativo o nel negativo, ben venga.
Qualunque di queste opportunità scelte ne farà essere, sempre ed esclusivamente, un rapporto unico. L’unicità di quelle o quella qualità ottenuta dalla traduzione-applicazione può però indurci a considerarlo di tipo monoglossico (un quadro astratto è monoglossico se si considera solo la sua astrazione o l’ipotetico titolo ad esso associato).
In un linguaggio esclusivamente detto, scritto o verbo-gestualizzato, si renderà indispensabile l’uso a predisporlo ad essere anche sostitutivo. Tutto l’iter, reso possibile da qualunque altro atto o sistema di comunicazione, si estenderà autonomamente nei contesti come via unica perseguibile.
Bel linguaggio, mi sono più volte detto. Di fatto, da “Lezioni di rettorica e belle lettere di Ugone Blair tradotte dall’inglese e commentate da Francesco Soave C.R.S. Tomo Primo, Secondo e Terzo per la tipografia Daddi di Firenze 1836”, ho così provato ad individuare la parola scritta recante il cosiddetto errore ortografico, lo stile, le sue qualità, la perspicuità e la precisione (pag. 175 Tomo Primo lezione X). Sempre è più volte mi sono dibattuto se lasciare o meno quell’impronta così come la mia traduzione-applicazione mi aveva suggerito di cogliere e di proporre, sempre e più volte mi sono trovato a correggere quella non regolare applicazione per non incorrere nell’indolenza del lettore e nella sua conseguente attribuzione, di ciò, ad un mio errore, meglio ignoranza. Mi sono sempre detto nella giustificazione: “È l'equivoco voluto dai Carmina Figurata, da Guillaume Apollinaire, dai Dada”.
Infatti, la definizione di un segno, di un atto, di un dire si conclude sempre in un valore puramente iconico, diviene esclusivamente un fatto visivo, un approccio ludico-decorativo le cui conseguenze sono inimmaginabili.
Sempre prendendo spunto dal mio abbecedario, tra inventare e scoprire ho trovato: “Si inventano le cose nuove e si scoprono quelle che prima erano nascoste”.
Mi sono detto: Galileo ha inventato il telescopio; Harvey ha scoperto la circolazione del sangue; L’uomo ha inventato i caratteri e le parole; Gutenberg ha scoperto come ripeterli affrancandosi.
Partendo dalla banale situazione, come in tutte le ricerche che tenderebbero alla “scoperta”, in una prima fase sperimentale, è immediata la consapevolezza che non è sufficiente scrivere la parola onbrello e non ombrello in modo che se ne tracci, nella disposizione grafica delle sue lettere, la corretta attribuzione di una regola.
Quasi sempre l’oggi è il di ieri e il di sempre. Staccare la parola in (on)brello o on-brello è per giustificarne un uso ed un’immagine di aperto o chiuso.
La stessa cosa è accaduta per la parola inpressione ed impressione. È il percorso in tutte le sue varianti di significato legate all’(in)prescindibile di una emme e di una enne. Tutte hanno avuto la necessità del giustificarsi con In-pressione o (in)pressione, con in-personale o (in)personale. Può capitatare persino, recentemente, il riporto in un testo poetico della parola pecularietà. “L’errore” è nel non averla volutamente divisa, nell’aver saltato la corretta applicazione della fase sperimentale, nell’aver rispettato, tout-court, il segno iconico determinato da un percorso logico dettato prioritariamente dal suo contesto.
É bastato l’attimo di una lettura, in cui non “figurava” il suo termine come sperimentale, per reclamare l’errore.
Scrivere Pecula-[ri-(Età)] probabilmente non avrebbe sortito alcuna lagnanza in tal senso, ma la sottolineatura mentale ad una non chiara utilizzazione.
La logica di una Concussione letteraria non avrebbe affermato figuratività di “Peculiarità” per la Crusca. Peculiarietà, ad esempio, non sarebbe stata nemmeno la Peculiarità. Ma era questo il solo intento? La domanda è lasciata sospesa.
Lo scrivere Peculiarità, probabilmente, avrebbe avvicinato il lettore a dare la credibilità ad una parola, ad un testo, il non scriverla, “correttamente”, ha dato dell’ignoranza. (l’accetto così come ammetto la stravaganza). Non è stato questo né sarà l’unico caso.
Anche il dichiarare che il Carducci è “un romantico” può essere sufficiente per ricevere una occhiataccia dalla professoressa abituata, scolasticamente, alla attribuzione accademica di quella “Verità”. Per i “rinchiusi”, non ammettendo l’evolversi di un’idea, è come avere di fronte a sé un orizzonte non espanso e non sostano nel dubbio creativo, quindi, non sono predisposti a dibattere. Ho pensato che un giorno, chissà, che Cristo potrà essere ritenuto Ateo.
(per non incorrere nell’equivoco, comunque, non essendo questa la licenza poetica, dirò che è altra cosa e non è questo il mio edit, è per adesso il mio audit).
Spero, un giorno, che mi capiti di dissertare anche su Carducci romantico e su un Gesù Ateo. In tutto questo: “una difficoltà imbarazza; un ostacolo arresta”.
Come vedete la cupola di un ombrello aperto, affinché il significante acquisti una duplicità di significato non è sufficiente. Così come non è sufficiente essere Paraglossici ossia dare al linguaggio solo i due elementi, quello visivo e verbale. Gli elementi, infatti, essendo posti in posizione parallela, uno come funzione didascalica, l’altro invece grafico-esplicativa, seguono i binari della logica del non “Errore”. Di fatto dovrei, ogni qual volta lo commetta, spiegare perché l’ho commesso travalicando il normale rinnovamento del pensiero-linguaggio-creazione ed il tempo ad esso dedicato come libera espressione.
Ahimè, andrei a sovrappormi allo stesso tempo che è stato percorso e dedicato da chi crede di avere il Verbo e, quindi, anche l’audacia di correggere. È un problema che restringe il campo, normalmente tutto questo è: “Ignoranza dell’iter di un Pensiero”.
Per ritornare alla Paraglossia, le lettere illustrate da un disegno o caricatura sono una vecchia e garbata facezia in uso nelle buone famiglie diceva Rossana Apicella e, quando l'epistolario è uno degli strumenti per lo scambio di notizie con i propri familiari, amici e congiunti, quell’episodio narrato con la parola diventa apodittico e pertanto oggi sostituito dalla comunicazione di un MSM o SMS.
Ecco allora che la Singlossia (incrocio di linguaggio visivo e verbale nel piano tri-pluri-dimensionale di spazio e tempo) diventa necessità ed impiego.
Per chi seguì le vicende della Singlossia, nate a Brescia, portate via da Brescia e poi continuate in Sicilia e nel Salento, in un seminario proposto dall’Amministrazione Comunale di San Pietro in Lama (dal 2 all’8 gennaio 1985) e volute da chi qui scrive come Progetto ’90 va detto che, l’interesse fu enorme e che quell’iter fu seguito ed arricchito da personalità della cultura d’avanguardia degli anni ’80 e dagli ambienti universitari leccesi, cito alcuni nomi:Bonea, Colombo, Augeri, Giannone, Vergallo, Miglietta, Manni, Balsebre, Carpentieri, l’allora Gruppo Gramma con (Fanciano, Pasca, Leo, Piano, Corallo), il Gruppo ’70 del fiorentino Miccini.
Il seminario allora proposto tracciava il punto sui contributi già iniziati nel 1979 presso il Liceo “Calini di Brescia” e traslati nell’1982 presso il Laboratorio  di Poesia di Novoli di Enzo Miglietta, Luogo indiscusso nel panorama figurativo-poetico- letterario Salentino. Gli Episodi culturali, in quel tempo, si moltiplicavano e se ne addizionavano tanti nelle cronache letterarie salentine ed internazionali. Quel fare era l’espressione più viva di una “provincia” che cercava l’approdo in contesti più ampi.
di Poesia di Novoli di Enzo Miglietta, Luogo indiscusso nel panorama figurativo-poetico- letterario Salentino. Gli Episodi culturali, in quel tempo, si moltiplicavano e se ne addizionavano tanti nelle cronache letterarie salentine ed internazionali. Quel fare era l’espressione più viva di una “provincia” che cercava l’approdo in contesti più ampi.
La prima forma Singlossica, apparsa nel 1978 si ebbe su soli due assi cartesiani con coordinata:S(ax,by). I “Valori” semantici assegnati a ciascun asse furono identici ed il risultato si esplicitò sull’inclinazione della retta esse pari a 45°. Gli assi cartesiani, rispettivamente, prendevano il nome di idosemantico e fonosemantico e l’allora Rassegna ebbe come nome Verifica 8+1. Chi qui scrive, successivamente, elaborò il (manifesto della Singlossia insieme alla semiologa Rossana Apicella e se discusse nei più prestigiosi convegni da Milano a Palermo nonché presso l’L.P.N. acronimo di Laboratorio Poesia Novoli. Questo negli anni tra 1982 e il 1984. In quel periodo si rilesse Nietzsche(articolo critico di Toti Carpentieri - Quotidiano di Lecce 21 giugno 1984) ed era l’inizio del Quanto Espresso, del Come si Semplifica e del Processo con cui ci si deve muovere lungo gli assi di quel piano.
Soprattutto, si trattò di un’esperienza in cui si iniziavano a dettare alcune “regole” fondamentali.
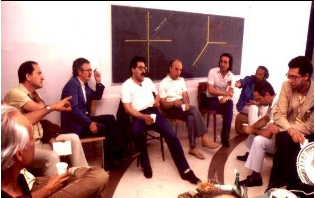 Iniziò nella serata del 12 giugno del ‘82, sulla lavagna a disposizione per l’iniziativa, il secondo e più importante passo veniva segnato, per la seconda volta, con quella teoria. (Bello il linguaggio della geometria e della matematica, disapprova l’errore e non lo può esprimere ed al contempo ti consente l’ipotesi e l’opportunità di dimostrare.)
Iniziò nella serata del 12 giugno del ‘82, sulla lavagna a disposizione per l’iniziativa, il secondo e più importante passo veniva segnato, per la seconda volta, con quella teoria. (Bello il linguaggio della geometria e della matematica, disapprova l’errore e non lo può esprimere ed al contempo ti consente l’ipotesi e l’opportunità di dimostrare.)
Questo permetteva di immergerci e, ancora oggi, trovo volentieri conforto in quei numeri. Sempre in quel convegno del 12 di giugno, i tradizionali assi cartesiani sul piano si proiettarono nello spazio, l’angolo diedro di Monge, il suo quadrante positivo, negativo o metafisico erano, divennero ed ancora sono l’opportunità. Ad ognuno di quegli assi si andò ad assegnare una parte di operazione creativa. All’asse delle x si prefigurava il linguaggio-idosemantico (visivo), all’asse delle y quello fonosemantico (verbale), all’asse delle z il diacronico (il “fatto linguistico” nel suo sviluppo attraverso il tempo). Sul piano ausiliario, divenuto proiezione spaziale e naturale attuazione di quel risultato, nasceva la Singlossia. La nuova risorsa si auto collocava assumendo sul piano la significata potenzialità della parola, S di coordinate(x,y,z).
I valori di x, di y e di z erano e sono i valori da assegnare in funzione dell’ottenimento di una determinata Singlossia sul piano .
Es: (si possono assumere anche valori uguali su ogni asse)
in questo caso:Rettangolo di base ABCD LATI x15 e y12, altezza z8.
La diagonale di base con Pitagora è rdqr 9^2+12^2=81+144=15 nonché la rdqr della coordinata di S sul piano orizzontale.
La diagonale del parallelepipedo è rdqr 15^2+8^2=225+64=17 nonché la coordinata di S nello spazio ottenuta come Singlossia.
Da ciò, non potendo, apparentemente, rappresentare le tre dimensioni di una parola, la si dovette scomporre come una forma semplice, come fosse quella della diagonale di un cubo o di un parallelepipedo. La diagonale S divenne la congiungente dei vertici opposti.
Variando il valore dell’idosemantico e del fonosemantico con il teorema di Pitagora si trova il Valore della diagonale S= radice quadrata di [(valore coordinata)^2 + (y)^2].
Non è da meravigliarsi se verrà ricondotta alla metrica latina che ci ha abituati a tutto questo.
A quel tempo, l’inizio degli anni ottanta, si accedeva ed iniziava così l’ingresso nel campo non più di una civiltà dell’immagine pura ma, della civiltà della Singlossia. Il punto S con il quale i linguaggi raggiunsero la loro complementarità, l’ESSE, in cui l'Uno, il tutto, è oggi il risultato ancora non comprensibile senza la presenza di alcuna di quelle valenze espresse per pura ortodossia.
L’attribuzione semantica di un “Valore”, attraverso l’uso di una coordinata, così facendo, dà Luogo alla Singlossia e la si definiva ieri e la si assume oggi come proseguo sperimentale, come il rifiuto di appartenenza a qualsiasi o quasi antenato letterario. Rossana Apicella aggiungeva:«anche se di nobile stirpe» ed aggiungeva ancora: «Le Avanguardie storiche sono del tutto  superate e La Singlossia, quindi, rifiuta la Monoglossia come linguaggio desueto e del tutto superato.
superate e La Singlossia, quindi, rifiuta la Monoglossia come linguaggio desueto e del tutto superato.
Intendo, ovviamente, la Monoglossia del nostro tempo (Omero resta Omero, perché il suo modo di esprimersi rispecchia il suo tempo e la sua fase storica). La Singlossia rifiuta tutta l'attuale cultura poetica di libri monoglossici ed attende che il tempo le dia giustizia. Rifiuta pertanto i Carmina Figurata, il Dada, Apollinare, La Poesia Concreta, la Poesia visiva e, si colloca... Siamo nella Poesia Ritrovata: non come "gesto Dada" insultante e gratuito, ma come un veleggiare sui vascelli che "per incantamento" ci devono portare verso i lidi di una “dolce follia”.» Per ricondurci alla storia, a quel punto, così come teorizzata, di Singlossia si interesserà Lamberto Pignotti e Stefania Stefanelli in "La Scrittura Verbo-Visiva le avanguardie del novecento tra parola e immagine" Espresso strumenti collana curata da Umberto Eco.
Nel 1983 a Lecce si unisce, si rifonda, il Gruppo Gramma con Francesco Pasca, chi scrive, ed ancora con Bruno Leo, Salvatore Fanciano, Giovanni Corallo e Beppe Piano. Il Gruppo si produrrà con performance poetiche nelle piazze Italiane e presso le biblioteche circondariali d’Italia.
La rivista L'Immaginazione n.10 dell’ottobre 1985 di Piero Manni, pubblicherà teorie e commenti sulla Poesia Visiva e sulla Singlossia. L’ultimo intervento pubblico del sottoscritto fu in Piazza Duomo a Lecce sul tema "Strappi temporali" con L’affermazione: «la condizione attuale della Poesia si presenta con alcune connotazioni fondamentali intrinseche al tempo che le genera. La prima di queste condizioni è il riproporsi di un nuovo interesse che la Poesia, nel suo spazio universale di proposte e ricerche, suscita nel fruitore, forse più sprovveduto, certo più appassionato, meno privilegiato ed elitario, del protagonista della fase storica conclusa dalla stagione del Maggio Francese.»
Ritornando agli inizi, questi i poeti visivi presenti alla prima mostra sulla singlossia nel 1979: Ignazio Apolloni, Mirella Bentivoglio, Francesco Pasca, Jan François Bory, Domenico Cadoresi, Ugo Carrega, Mirko Casaril, Achille Cavellini, Vitaldo Conte, Carlo Marcello Conti, Angelo Mino Doninelli, Flavio Ermini, Jochen Gerz, Michele Lambo, Lucia Marcucci, Silvano Martini, Nino Majellaro, Eugenio Miccini, Fulvio Milani, Luciano Morandi, Luciano Ori, Giancarlo Pavanello, Enrico Pedrotti, Michele Perfetti, Paolo Racagni, Lamberto Pignotti, Luigi Rifani, Demos Ronchi, Vitantonio Russo, Salvatore Salomone, Sarenco, Guido Savio, Franco Spena, Gigi Viola, Rodolfo Vitone, Andrea Vizzini.
Il Maggio Francese occorre ricordalo come la «bataille d'Hernani» e reinventarlo nella nuova «bataille», infatti è «bataille» come convenzionalmente fu l'inizio del Romanticismo in Francia, come fu la querelle tra antichi e moderni. S’attuò il nuovo dramma, che riscuoterà nuovi successi con il «linguaggio chiuso», la rarefazione preziosa della parola, la parola che allude ed evoca. Dalla rivista letteraria Ippocrene uno stralcio di questa nuova disputa a mia firma. «La Singlossia nel racconto: Il testo scritto, la narrazione, è tutt’altra cosa; la Singlossia, sino ad oggi, supportata da testi brevi e simultaneità di brevissimi sprazzi temporali, non poteva continuare ad essere solo pause pensate, suggerite e non scritte, costretta a continuare ad essere solo testo visivo, ma doveva diventare tutt’altro e, al contempo, non perdere la sua atavica caratteristica evocatrice.
In occasione della mia ultima mostra sulla Singlossia bresciana, ebbi a scrivere e a rendere omaggio a Marinetti prima, a Rossana Apicella. Li omaggiai con la seguente poesia dal titolo:
“Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” accompagnata dal sottotitolo “che il tuo treno travolga”
Fischiava e sbuffava le sue parole ascoltava/snodava i rimbalzi/su Paralleli Pensieri/su file operose/su schizzi di mete moltiplicate dal nulla/fischiava il suo Fare/corsivo e nervoso su rotaie con Segni minuti/Provava a trovare/a cercare/a sostare/Sentiva il sostare/Trottava il suo Fare//Sbuffava trottava/Sbuffava//trottava Sbuffava//[…] sbuffava Visioni di soste/parziali Frammenti di sete/partenze Mai spese/come Echi trascorsi in Stazioni Sperate...//Sbuffava trottava/Sbuffava fischiava//trottava Sbuffava/fischiava/Sbuffava fischiava Fischiava//come Echi trascorsi in Stazioni Lasciate...
Con un’altrettanta mostra sulla Singlossia in una galleria di Milano, di cui non ricordo né il Luogo né il Tempo, si concludeva l’esperienza nata al “Calini” di Brescia ed osteggiata, anche in questo caso, dai Sancta Sanctorum della Poesia Visiva,(ve ne sono i tutti i luoghi), gli stessi che si avventarono sulle spoglie mortali di Rossana a contendersi quell’eredità culturale e, ancora oggi, la quasi totalità, la ostenta o la ha ostentata senza apportarne significato. Tra i miei documenti personali, lettere a me indirizzate da Rossana, sul suo classico foglio quadrettato, rigorosamente scritte di pugno, appaiono le testimonianze di quella inesorabile contesa con il mondo Verbo-Visivo Fiorentino, Milanese, Veneto, Marchigiano, Siciliano ed altri.
Fra i pochi continuatori rimasti di quel linguaggio, il più dinamico è certamente Ignazio
Apolloni, sebbene, del suo Intergruppo, si registrino oggi poche e significative testimonianze di vera Singlossia. La S. viene allontanata o ripresa secondo regole dettate esclusivamente dalla circostanza. Non ha avuto la sorte che gli spettava: “attende ancora giustizia”…»
La situazione ermetico-iniziatica interesserà la sonnolenza del «territorio» inteso come spazio di una cultura borghese. Le posizioni in battaglia prevedono le strategie e si devono affidare ad un discorso lucido ed esplicito. Poesia e Storia della Parola. Polibio “volle” con i suoi scritti la gloria degli Scipioni, ma il suo linguaggio era di una civiltà morente: Polibio lo volle in greco mancando l’aggancio con la romanità carolingia e dantesca. Polibio fu solo epico. Tuttavia. Polibio non valicò i confini dell'età classica. La Singlossia è tempo lessicale e di costume, è fenomeno fondante, verificato nel contatto quotidiano con la realtà. La Singlossia è interpretazione del tempo esprimendosi con e nel linguaggio del tempo. È l’espansione del linguaggio, ne aumenta il processo diacronico e tende a rendere transitivi i verbi intransitivi, in modo da eliminare la perifrasi espressa mediante la funzione e induce ai diversi significati che sono indicati dall'accentuazione, intonazione e la tipica espressione di valore nell’esecuzione fonica di un linguaggio. Più orale che espresso attraverso la sola astrazione grafica. La Singlossia di più recente generazione, è destinata ad un uso di un linguaggio a forte carica allusiva, in cui le metafore sono generate a catena. Non hanno valore puramente semantico ma, una semantica a volte caricaturale e dissacratoria. La dissacrazione che fa sorridere è spiegare il fenomeno come azione di regressione culturale esercitata dagli studi classici, dalla gravitas sconfinante in una Rettorica Asiana suggerita dalla lettura di Cicerone o Quintiliano, o, semplicemente, nel credere che è bello avere di letteratura, sapere di Rettorica, solo quando è stata del tutto dimenticata. Sorpresa, sgomento e meraviglia hanno due aspetti: 1) se espressi solo attraverso il segno di supersegmentazione, sottintende il gesto; 2) se espressi mediante una immagine, la parola supersegmentata può essere sostituita dal gesto. In questo contesto resiste ancora la Poesia Visiva che ahimè è identificabile nella sua fenomenologia statica di Scrittura meramente Visuale ma, non è superamento della Scrittura Poetica, non è proposta futuribile nella sterminata problematicità semantica. Rimane l’utilità del linguaggio in contrapposizione alle ragioni veicolate mediante un sistema di simboli non più finiti ma, arbitrariamente combinati solo in un non accordo alle regole, per ora, della sola grammatica.
"il destino è nel nome" diceva una vecchia massima latina. La Singlossia è oggi il corrispondente di un I touch e rispecchia alla perfezione la logica dell’assonanza, è il multimediale nella metafora, il nuovo "magico" linguaggio della fruizione, il tanto atteso multitasking del pensiero creativo.
Parlavo innanzi dell’inventare e dello scoprire, voglio concludere con Omero, coi versi per bocca di Penelope nel lagnarsi della partenza di Telemaco:«Perduto ho lo sposo già da gran tempo, scudo della mia patria, onor dei Greci, ed or le tempeste hanno portato seco l’altra colonna dello stato, senza che abbia preso da me congedo, e chiesto il mio consentimento …» (traduzione di Alexander Pope - Londra, 22 maggio 1688 – Twickenham, 30 maggio 1744).
Qui è evidente, nelle metafore, che Telemaco è figurato colonna, poi, torna persona. La mescolanza contro natura(letterale) rende quell’immagine indistinta e la fa ondeggiare fra il senso figurato e il letterario, non è il difetto dell’unire il semplice con il metaforico ma l’abbracciare. Finisco con il ricordare i contributi di altri gruppi, di altri personaggi-autori. Ne cito alcuni per l’aver consegnato l’enorme contributo al Salento ed al Linguaggio. Loro hanno partecipato con un’avventura a me parallela, distanti dai luoghi ma vicini negli intenti. L’(ES)SE in cui vi è quel vissuto sono anche l’esperienza di Saverio Francesco Dòdaro. L’avanguardia meridionale è stata la stagione del fare e dell’assoluta convinzione del fare. È stata la storia da me vissuta a Brescia e parallelamente da un altro gruppo di scalmanati a Lecce. É stato il BALLYHOO-LETTERATURE (il DECLARO), il brogliaccio di Antonio Verri con Mauro Marino e Maurizio Nocera. È stato soprattutto Antonio Leonardo Verri (Caprarica di Lecce, 22/02/1949–09/05/1993), il romanziere, il poeta, il pubblicista e l’editore italiano inquadrabile nel filone del postmodernismo letterario. A lui si deve il dibattito letterario degli anni ottanta dell'Avanguardia meridionale. I cosiddetti "poeti maledetti salentini" (detti anche "selvaggi salentini"), tra cui figura anche Salvatore Toma. Poeti indispensabili.
Ricordo le riviste letterarie Caffè Greco (1979-1981), Pensionante de' Saraceni (1982-1986) e Quotidiano dei Poeti (1989-1992). Sempre con Antonio Verri transita il poeta di Finibusterrae e Antonio Errico che cominciò a collaborare in “Pensionante de’ Saraceni”, una rivista straordinaria. Mi pregio nel dire che molto simili furono l’esperienze. In tutto questo è stata anche la Singlossia come uno stato dell’in-conscio. È stata la Singlossia che: “Non è inventare ma scoprire, meglio se iperbolizzare.” Ma di quest’ultima storia avrò modo di approfondire, gli amici di oggi mi saranno di grandissimo aiuto. Così scrive Antonio Errico:«Aveva un sogno Antonio Verri, il grande folle sogno di un libro profondo e immenso, smisurato, che fosse tutto e nulla, riflesso e inconsistenza, nuvola e macigno. Perfezione. Sognava un libro, Verri: una forma gigantesca, gravida di corpi, di linguaggi, di silenzi e voci, di segni d’ogni sorta, insegne luci balbettii colori. E poi brusii, poi ritmi affannosi o pacati, come fossero respiro, palpito di cuore.»(da Apulia Marzo 2002).
Così rispondeva Antoni Verri:« Fate fogli di poesia poeti, vendeteli per poche lire! » (dal manifesto poetico di Antonio L. Verri).