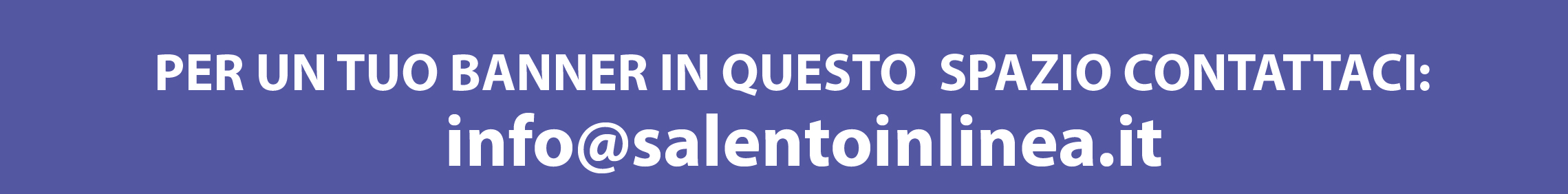«Il buon giornalista è quello che riesce, con i suoi articoli o servizi televisivi o radiodiffusi, a spiegare agli altri ciò che non ha compreso lui». Evidente il paradosso ma neppure tanto peregrino. Sissignori è una dote anche quella e attuata da quelli bravi. Premesso che il giornalista non è e non sarà mai il detentore dello scibile egli è uno incuriosito dai temi più disparati e siccome i concetti sono spesso confusi dalle situazioni complesse si serve della scrittura per mettere in fila le idee. E lo fa in ossequio all'adagio che recita: «la scrittura è la cassetta degli attrezzi con cui aggiustare i pensieri». Ma, in questo caso, parliamo degli articolisti tuttologi laddove l'aggettivo neologistico affibbiato agli editorialisti che discettano su tutto, pur avendo un'accezione ironica se non dispregiativa in realtà può nascondere una qualità non comune. Fatte le debite proporzioni anche il medico generico indirizza verso lo specialista ma è il primo ad impattare col problema, in questo caso sanitario, indi orienta il paziente verso le analisi richieste per rilevare la patologia e affrontarla con cognizione di causa. Analogamente il redattore fatta la prima spiega dell'evento o della situazione rinvia, chi è interessato, agli approfondimenti e, per questo, rifulgono i giornalisti specializzati. Ma la competenza, assai spesso, quando i temi non sono propriamente... laici si «imbastardisce» con le opinioni e qui subentrano le aporìe, gli anfiboli, ovvero l'impossibilità di dare soluzione ad una tesi perché è vera sia la sua spiegazione che l'opposto di questa. A tal proposito è eloquente nella visione dei talk-show come il pubblico in sala applauda il convenuto a parlare e subito dopo renda ugual plauso al suo oppositore. Attenzione! non si tratta di fazioni, ho colto a percuotersi i palmi le stesse persone. E qui lo scrosciar di applausi è fuorviante e bisognerebbe metterci pezza semplicemente abolendoli. È questa una delle motivazioni (non l'unica!) per cui questo giornale e il suo direttore hanno inteso, come linea editoriale, cassare dai suoi contenuti le argomentazioni afferenti alla politica. Sono già in tanti ad occuparsene, di questa, che si è preferito uscire dal chiasso che la caratterizza. Bisogna fare delle scelte e ogni scelta per definizione implica una rinuncia. Meditata. La polverizzazione delle testate giornalistiche propugnate dall'avvento della rete internet ha avuto l'effetto di uno tsunami, sì, sono rimasti i giornali cartacei, quelli che ancora fanno testo perché i loro titoli (la linea) sono citati nelle rassegne stampa del primo mattino o della tarda ora, ma non si dice più «l'ho letto sul giornale!», giornale che ha dilavato quella spinta al convincimento delle opinioni nazionali. Rovescio della medaglia in questo mutato scenario è la possibile mancanza di professionalità con conseguente latitanza deontologica; abbiamo un Ordine, per questo, quello dei giornalisti, dedito a sovrintendere a far rispettare regole scritte e non scritte. Ma la lotta è impari. Prima di internet quella dei giornalisti appariva come una lobby in grado di orientare opinioni e scelte, una sorta di oligarchia del pensiero (unico!?), e gli altri potevano essere soltanto mero orecchio esclusi dalla possibilità di passare dal senso dell'udito all'uso della favella. Adesso, sia pure con audience diversificate nel numero, ciascuno può esprimersi. Enorme il contributo alla democrazia e al pluralismo. Ma il rischio è di aver traslato dai bar alla rete il chiacchiericcio sulle questioni cogenti. Sta a noi cernere e discernere diventando gli onesti intellettuali di noi stessi, individuando le truffe semantiche e filtrando i tentativi di manipolazione. Tributiamo pure alle teste d'uovo la capacità di rendere paratattici i pensieri ingarbugliati, ma l'era delle deleghe in bianco non è più funzionale. Bene. Per concludere, volete un esempio di giornalismo approssimativo? Se siete arrivati in fondo a questo scritto lo avete avuto.
«Il buon giornalista è quello che riesce, con i suoi articoli o servizi televisivi o radiodiffusi, a spiegare agli altri ciò che non ha compreso lui». Evidente il paradosso ma neppure tanto peregrino. Sissignori è una dote anche quella e attuata da quelli bravi. Premesso che il giornalista non è e non sarà mai il detentore dello scibile egli è uno incuriosito dai temi più disparati e siccome i concetti sono spesso confusi dalle situazioni complesse si serve della scrittura per mettere in fila le idee. E lo fa in ossequio all'adagio che recita: «la scrittura è la cassetta degli attrezzi con cui aggiustare i pensieri». Ma, in questo caso, parliamo degli articolisti tuttologi laddove l'aggettivo neologistico affibbiato agli editorialisti che discettano su tutto, pur avendo un'accezione ironica se non dispregiativa in realtà può nascondere una qualità non comune. Fatte le debite proporzioni anche il medico generico indirizza verso lo specialista ma è il primo ad impattare col problema, in questo caso sanitario, indi orienta il paziente verso le analisi richieste per rilevare la patologia e affrontarla con cognizione di causa. Analogamente il redattore fatta la prima spiega dell'evento o della situazione rinvia, chi è interessato, agli approfondimenti e, per questo, rifulgono i giornalisti specializzati. Ma la competenza, assai spesso, quando i temi non sono propriamente... laici si «imbastardisce» con le opinioni e qui subentrano le aporìe, gli anfiboli, ovvero l'impossibilità di dare soluzione ad una tesi perché è vera sia la sua spiegazione che l'opposto di questa. A tal proposito è eloquente nella visione dei talk-show come il pubblico in sala applauda il convenuto a parlare e subito dopo renda ugual plauso al suo oppositore. Attenzione! non si tratta di fazioni, ho colto a percuotersi i palmi le stesse persone. E qui lo scrosciar di applausi è fuorviante e bisognerebbe metterci pezza semplicemente abolendoli. È questa una delle motivazioni (non l'unica!) per cui questo giornale e il suo direttore hanno inteso, come linea editoriale, cassare dai suoi contenuti le argomentazioni afferenti alla politica. Sono già in tanti ad occuparsene, di questa, che si è preferito uscire dal chiasso che la caratterizza. Bisogna fare delle scelte e ogni scelta per definizione implica una rinuncia. Meditata. La polverizzazione delle testate giornalistiche propugnate dall'avvento della rete internet ha avuto l'effetto di uno tsunami, sì, sono rimasti i giornali cartacei, quelli che ancora fanno testo perché i loro titoli (la linea) sono citati nelle rassegne stampa del primo mattino o della tarda ora, ma non si dice più «l'ho letto sul giornale!», giornale che ha dilavato quella spinta al convincimento delle opinioni nazionali. Rovescio della medaglia in questo mutato scenario è la possibile mancanza di professionalità con conseguente latitanza deontologica; abbiamo un Ordine, per questo, quello dei giornalisti, dedito a sovrintendere a far rispettare regole scritte e non scritte. Ma la lotta è impari. Prima di internet quella dei giornalisti appariva come una lobby in grado di orientare opinioni e scelte, una sorta di oligarchia del pensiero (unico!?), e gli altri potevano essere soltanto mero orecchio esclusi dalla possibilità di passare dal senso dell'udito all'uso della favella. Adesso, sia pure con audience diversificate nel numero, ciascuno può esprimersi. Enorme il contributo alla democrazia e al pluralismo. Ma il rischio è di aver traslato dai bar alla rete il chiacchiericcio sulle questioni cogenti. Sta a noi cernere e discernere diventando gli onesti intellettuali di noi stessi, individuando le truffe semantiche e filtrando i tentativi di manipolazione. Tributiamo pure alle teste d'uovo la capacità di rendere paratattici i pensieri ingarbugliati, ma l'era delle deleghe in bianco non è più funzionale. Bene. Per concludere, volete un esempio di giornalismo approssimativo? Se siete arrivati in fondo a questo scritto lo avete avuto.
Giornalismi e tuttologie
- Giuseppe Pascali
- Visite: 492